Etichettato: Diritto
La buona vendetta
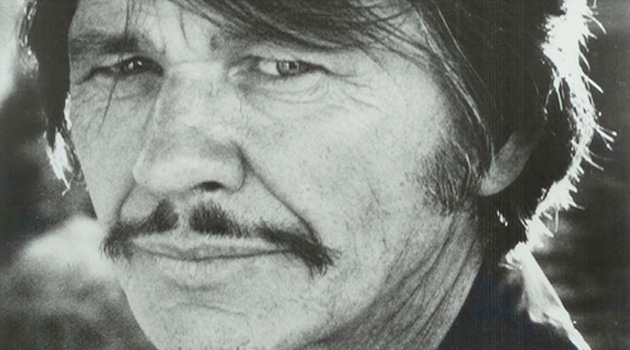 Alcune recenti assoluzioni hanno suscitato un certo clamore nell’opinione pubblica. Dal caso Cucchi, in cui pare chiaro che un ragazzo sia stato picchiato, ma la legge non sa dire da chi e assolve gli imputati, alla prescrizione per il caso Eternit, in cui le parole del procuratore generale della Cassazione (“ci sono momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte”) hanno dato la stura a una protesta basata su un senso diffuso di giustizia mortificato da quella che, in modo anche sprezzante, viene definita ‘legalità formale’. A Ferguson, negli Stati Uniti, la recente mancata incriminazione dell’agente (bianco) che sparò e uccise un adolescente (nero) disarmato ha scatenato nuovamente la protesta, sfociata in danneggiamenti, ferimenti, arresti. Lo stesso è accaduto per la mancata incriminazione dell’agente che con una mossa vietata ha strangolato l’afroamericano Eric Garner, di Staten Island, New York. Negare giustizia in nome della legge. Il ragionamento è: sappiamo di chi sono le colpe, ma il diritto (sarebbe meglio dire la legge) ne ostacola l’accertamento. Summum ius, summa iniuria. A un caldo senso di giustizia si contrappone la fredda legge dello Stato. Alla reazione immediata (‘a caldo’), la lentezza delle procedure. Il diritto così risulta velleitario, inefficace nella sua pretesa di fare giustizia espropriando le parti in causa del diritto di farsi giustizia da sé, in nome di una razionalità astratta che dovrebbe offrire garanzie di terzietà scongiurando il rischio di una gestione emotiva e irrazionale del conflitto. Il diritto, si sostiene, serve a scongiurare la vendetta.
Alcune recenti assoluzioni hanno suscitato un certo clamore nell’opinione pubblica. Dal caso Cucchi, in cui pare chiaro che un ragazzo sia stato picchiato, ma la legge non sa dire da chi e assolve gli imputati, alla prescrizione per il caso Eternit, in cui le parole del procuratore generale della Cassazione (“ci sono momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte”) hanno dato la stura a una protesta basata su un senso diffuso di giustizia mortificato da quella che, in modo anche sprezzante, viene definita ‘legalità formale’. A Ferguson, negli Stati Uniti, la recente mancata incriminazione dell’agente (bianco) che sparò e uccise un adolescente (nero) disarmato ha scatenato nuovamente la protesta, sfociata in danneggiamenti, ferimenti, arresti. Lo stesso è accaduto per la mancata incriminazione dell’agente che con una mossa vietata ha strangolato l’afroamericano Eric Garner, di Staten Island, New York. Negare giustizia in nome della legge. Il ragionamento è: sappiamo di chi sono le colpe, ma il diritto (sarebbe meglio dire la legge) ne ostacola l’accertamento. Summum ius, summa iniuria. A un caldo senso di giustizia si contrappone la fredda legge dello Stato. Alla reazione immediata (‘a caldo’), la lentezza delle procedure. Il diritto così risulta velleitario, inefficace nella sua pretesa di fare giustizia espropriando le parti in causa del diritto di farsi giustizia da sé, in nome di una razionalità astratta che dovrebbe offrire garanzie di terzietà scongiurando il rischio di una gestione emotiva e irrazionale del conflitto. Il diritto, si sostiene, serve a scongiurare la vendetta.
Ma è davvero così? E la vendetta è davvero un male? Sono le domande che percorrono il libro di Stefano Berni e Giovanni Cosi, studiosi di antropologia giuridica e di filosofia del diritto, i quali nel loro Fare giustizia. Due scritti sulla vendetta (Giuffrè 2014) provano in modo anche provocatorio a guardare a una vicenda umana ancestrale e indicibile: farsi giustizia da sé. Entrambi i saggi di cui il libro si compone si inseriscono in una più generale critica della modernità, intesa come il percorso che ha portato gli Stati a sottrarre ai cittadini il loro diritto di usare la violenza, per appropriarsene monopolisticamente. Ma questo esproprio, avvenuto sotto le insegne della razionalità fredda e calcolante, ha davvero escisso la violenza ancestrale che contraddistingue la vendetta? La risposta è no: il monopolio della punizione diventa vendetta di Stato (così come nel cristianesimo la vendetta è di dio, non più degli uomini). Eppure, sostiene Berni, se lo Stato non dà giustizia, l’ira che presiede alla vendetta si trasforma in risentimento. La vendetta aveva il pregio di consentire che l’ira si incanalasse: dopo lo scoppio del bubbone, l’ordine sarebbe tornato. La denegata giustizia dello Stato alimenta quel risentimento, al quale è necessario, sostiene Berni, trovare un canale di sfogo, poiché, al di là delle pretese illuministiche sulla rieducazione e sul reinserimento sociale del condannato, la giustizia è rimasta fondamentalmente retribuzione del male con un male uguale e contrario. Vendetta, appunto.
Diverso l’orientamento del saggio di Cosi, il quale prova a formulare una teoria della ‘buona vendetta’. Nella vendetta vi era un rapporto diretto tra la vittima e il reo (e le due comunità di riferimento): con la modernità questo rapporto viene seppellito in nome della terzietà del giudice, che non è, non può essere parte in causa. Ma questa elisione della relazione sociale è un danno, poiché da una parte sul reo si abbatte lo stigma di delinquente, rendendo illusoria la pretesa di reinserimento, mentre la vittima dal canto suo riceverà un astratto risarcimento che niente sa di ciò che essa desidererebbe come riparazione da parte di colui che le ha fatto del male.
La vendetta invece poteva anche trasformarsi in riconoscimento e conciliazione. Il processo penale che mira a stabilire pene e a comminare sanzioni è riduttivo, elide la relazione sociale. C’è bisogno, dunque, di una ‘vendetta buona’, che Cosi identifica nella mediazione penale, ovvero in un modo di risoluzione delle controversie che non ha bisogno del giudice, ma che si basa su un confronto diretto tra il reo e la vittima. Così il reo guarderà in faccia l’offeso, e questi potrà chiedergli ‘perché l’hai fatto?’, e pretendere da lui una prestazione compensativa diversa dalla detenzione. Negli Stati Uniti sono diffuse per esempio pene alternative che si sostanziano in lavori da svolgere, nel pagamento di spese mediche, e nelle scuse. Si tratta di una giustizia non retributiva (male contro male) ma riparativa. Una vendetta ‘buona’, che costringe il reo a guardare la sua vittima negli occhi, a stabilire un contatto.
Entrambe le proposte presuppongono una comunità che abbia voglia di fare giustizia da sé. Ma è una visione sostanzialistica che spaventa. Se è vero che la vendetta è una presenza spettrale anche nel diritto moderno, cosa c’è di male nel tentare di arginarla? Cosa di sbagliato in una razionalità che si pretende (con tutti i limiti del caso) fredda e distante dall’emotività del momento? E in fondo, non è più afflittivo (e pre-moderno) pretendere che il reo guardi in faccia la vittima, che gli chieda perdono, che cambi mentalità? Infine, la vendetta è dissipativa, si esaurisce nel gesto, mentre sarebbe il caso di incanalare l’ira per cambiare l’assetto ingiusto della società.
[* Una versione leggermente diversa di questo articolo è apparsa su Pagina99 – Weekend, Anno I, numero 70, 29 novembre – 5 dicembre 2014, p. 29]